Violenza. Il linguaggio della sicurezza nelle manifestazioni
- Laura Santilli

- 3 mar 2021
- Tempo di lettura: 10 min
Aggiornamento: 4 set 2021

Se il diritto di manifestare pubblicamente è una delle massime espressioni del grado di libertà e di salute di una democrazia, la violenza con cui le manifestazioni vengono represse in Europa, è ormai uno degli indicatori che il processo democratico è in una fase di profonda crisi. Sebbene questa non sia un’evidenza esclusiva europea, questa analisi vuole concentrarsi sulle forze di polizia europee e sulle loro differenti strategie di mantenimento dell’ordine per decostruire la narrativa spesso governativa, dell’utilizzo della violenza da parte delle forze dell’ordine come garanzia di sicurezza e quindi, protezione dei cittadini.
1. Aumento delle manifestazioni in Europa
A partire dal 2010, dopo lo scoppio della crisi economico-finanziaria in Grecia, l’Europa è divenuta a mano a mano protagonista di un aumento crescente del numero di manifestazioni e di una conseguente e parallela crescita di strumenti e strategie di gestione delle folle che sempre più spesso fanno ricorso a un uso esponenziale e indiscriminato della violenza. Le motivazioni che hanno spinto e acceso queste manifestazioni sono state spesso di ordine interno, legate a modifiche costituzionali in materia di legge sul lavoro, legge elettorale o di tagli alla spesa pubblica in materia di welfare, istruzione e cultura. L’inasprimento delle misure restrittive in termini di sicurezza e libertà individuali a seguito degli attacchi terroristici in Europa ha dato poi, nuova linfa vitale alle manifestazioni.
Dal 2015, la risposta di ogni governo europeo, in modo particolare di quello francese, é stata la repressione, sempre più violenta di queste proteste. Verrebbe spontaneo, ricordando magari, le immagini delle manifestazioni dei movimenti Nuit Debout prima e dei Gilets jaunes in Francia, o del referendum per l’indipendenza della Catalogna, rispondere che la violenza della polizia è direttamente proporzionale alla violenza espressa dai manifestanti. “L’infiltrazione sistematica di estremisti violenti all’interno dei cortei, ha portato le forze dell’ordine a modificare la loro dottrina di gestione delle manifestazioni”, scrive così Gérald Darmanin, attuale ministro dell’Interno francese, nel nuovo documento dello Schema Nazionale di mantenimento dell’ordine, esprimendo proprio il concetto alla base di quella che era stata la nostra prima risposta. Alla violenza degli estremisti la polizia deve rispondere con eguale violenza, quale governo può permettersi di essere altrimenti ingenuo, o naif per rimanere in ambito francese e pensare di rispondere contenendo la violenza o, peggio ancora, utilizzando strumenti cosiddetti “bianchi”, che non prevedono il contatto diretto con il manifestante? Non si può ritenere plausibile che un governo cerchi un dialogo con i violenti. Ma chi sono poi, questi “violenti”? Se si tratta di infiltrati, allora perché le forze dell’ordine disperdono e gestiscono l’intero corteo utilizzando strumenti violenti? Perché, pur essendo una minoranza, i violenti riescono a monopolizzare l’attenzione all’interno di una manifestazione?
La gestione delle folle e il mantenimento dell’ordine pubblico sono uno dei temi più complessi all’interno delle tecniche e procedure di sicurezza, anche perché strettamente legato ai diritti e alle libertà personali di movimento ed espressione e perché reo di facilissima politicizzazione.
2. L’azione differente delle polizie europee nelle manifestazioni
In ogni Paese europeo, sono le forze di polizia a detenere l’esercizio pubblico e il compito di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico durante le manifestazioni. In ogni Paese europeo, tuttavia, le metodologie di dispersione delle folle e di gestione dell’ordine pubblico sono differenti, soprattutto in termini di mezzi utilizzati e della conseguente violenza.
La Francia è il Paese in cui, a partire dal 2015, si assiste a un aumento della brutalità nella risposta delle forze di polizia. Secondo differenti rapporti dell'Osservatorio delle pratiche di polizia (OPP), la Francia dispone infatti, di "un livello molto elevato di armi" per le operazioni di polizia e la dottrina della polizia sul mantenimento dell’ordine pubblico, consiste principalmente nel tenere a distanza i dimostranti mediante dispositivi di distanziamento, come i cannoni ad acqua, gas e granate lacrimogene, le cosiddette bombe a mano “assordanti", gli LBD (lanceur de balle de défense) 40, proiettili di gomma, sono usati frequentemente. Ogni agente di polizia, inoltre, dispone personalmente di altre armi, tra cui pistole automatiche, fucili AMD, fucili d’assalto Famas e carabine. L’Italia segue la Francia in termini di armi utilizzate dalla polizia: pistole automatiche, fucili lanciagranate, granate lacrimogene e l'impiego di cannoni ad acqua per disperdere le folle. La polizia spagnola è invece l’unica in Europa a utilizzare una tecnica di dispersione delle folle tipica degli Stati Uniti: i dispositivi sonori a lungo raggio (LRAD) che emettono suoni a decibel molto elevati. Anche in Spagna gli agenti di polizia sono armati di fucili con proiettili lacrimogeni, flash ball, bastoni di difesa e, soltanto in Catalogna, di LBD, lanciatori di proiettili di gomma.
Le strategie di ordine pubblicano cambiano in nord Europa, dove diminuisce proporzionalmente anche la violenza esercitata dalla polizia durante le manifestazioni: in Germania, il controllo delle manifestazioni è materia di competenza dei Länder e gli agenti di polizia non intervengono armati, ma a mani nude. La polizia di Stato non interviene e i cannoni ad acqua sono ampiamente utilizzati per disperdere le folle, ma dopo le dimostrazioni. In Belgio, l'accento è posto sulla "de-escalation", con il principio di evitare il contatto e il confronto con i manifestanti e viene privilegiata la negoziazione con gli attori più estremisti. In Inghilterra, solo il 5% delle forze di polizia è armato durante le manifestazioni e viene utilizzata una pratica nota come “encagement”: la polizia cioè, circonda i manifestanti più violenti intervenendo per accerchiarli e isolarli dal resto dei manifestanti.
Paragonare i differenti modi di intervento della polizia nei Paesi europei, ci aiuta a porre in luce un altro aspetto, quello della formazione delle forze dell’ordine. Il maggior equipaggiamento durante gli interventi corrisponde infatti, a una minore formazione degli agenti di polizia. Come spiega il sociologo Sebastian Roché, in Francia, alla formazione degli agenti sono dedicati 8 mesi di teoria e 16 di pratica, mentre in Germania, in Norvegia e Finlandia, la formazione degli agenti dura 3 anni. Il sociologo spiega che, riducendo il periodo di formazione, gli agenti imparano a farsi rispettare con la forza, mentre è essenziale che questi imparino a farsi rispettare per la loro capacità di comunicare, a meritare il rispetto per conquistare la fiducia dei manifestanti, seguendo quello che in Inghilterra è noto come il principio del “policing by consent”. Fabien Jobard, sociologo, spiega inoltre che in Francia, differenti misure governative hanno ridotto il numero delle forze specializzate nel mantenimento dell’ordine, mentre si domanda agli agenti non specializzati, che non hanno quindi una formazione precisa, di intervenire sempre più di frequente, mettendoli per primi in pericolo. Anche Jobard spiega che, se gli agenti non sono formati in modo adeguato e con il giusto tempo, questi risponderanno solo in modo impulsivo e quindi violento, in reazione a determinate situazioni.
La scelta sulla formazione degli agenti e sui metodi di risposta è governativa, dunque politica e sebbene lo stesso ministro dell’Interno francese, Darmanin ha riconosciuto che gli ultimi governi francesi hanno commesso il grave errore di diminuire la formazione degli agenti, ciò che resta primario e fondamentale per i governi è reprimere in modo rapido e sistematico le frange estreme e gli individui violenti, spesso dei veri e propri “agenti provocatori”.
3. Il ruolo degli agenti provocatori
Sempre più organizzatori della resistenza civile e delle manifestazioni, sono consapevoli dei gravi problemi causati da attivisti fuorviati, che sostengono o si impegnano in attività violente di fianco ad azioni di resistenza civile. La violenza dei movimenti e la distruzione non strategica di auto, negozi, strade, tende a ridurre la partecipazione popolare, a spaventare i potenziali sostenitori, a giustificare un aumento della repressione anti-movimento e a diminuire la speranza di riforme o rivoluzioni democratiche. In breve, questo tipo di comportamento violento da parte di alcuni attivisti rende i movimenti più piccoli, più deboli e meno efficaci.
Meno organizzatori, tuttavia, sono consapevoli di come le élite di potere utilizzino spesso dei veri e propri "agenti provocatori" sotto copertura per infiltrarsi nei movimenti e fingere di essere attivisti. Il loro fine e quindi quello governativo è proprio quello di aumentare la quantità di comportamenti dannosi attribuiti ai movimenti nel tentativo di renderli più piccoli, più deboli e meno efficaci. Questa è una pratica comune nella storia dei movimenti sociali, che non deve sorprenderci. Come scrive il sociologo Gary T. Marx nel suo saggio sugli agenti provocatori, nell'Enciclopedia dei movimenti sociali e politici: “Quando le autorità o le élite sono sfidate da un movimento sociale, possono ignorarlo o rispondere con una varietà di strumenti che vanno dalla cooptazione al reindirizzamento, alla repressione. Una forma estrema di quest'ultima è la provocazione. L'idea dell'agente provocatore è entrata nella coscienza popolare nel XIX secolo, quando l'Europa ha sperimentato i conflitti associati all'industrializzazione e all'urbanizzazione. Il concetto [si riferisce] a un attivista che lavora segretamente con le autorità, che potrebbe fornire informazioni, seminare sospetti e dissensi interni, e/o provocare azioni violente che rivolterebbero l'opinione pubblica contro un movimento sociale e offrirebbero basi legali e morali per la sua repressione”[1].
Durante le mobilitazioni pubbliche, gli agenti provocatori urlano contro i manifestanti, li prendono a pugni, rompono finestrini, ribaltano auto, appiccano incendi, saccheggiano negozi e combattono per le strade con la polizia. In molti casi, hanno anche cercato di incoraggiare gli attivisti del movimento, sinceri ma fuorviati, a impegnarsi in tali comportamenti dannosi - o di intrappolarli in azioni ancora più distruttive. Il tutto proprio con l'obiettivo di rendere i movimenti più piccoli, più deboli e meno efficaci.
Nel libro, “Politica della lotta non violenta”, Gene Sharp spiega la logica strategica che guida le élite di potere in tutto il mondo ogni volta che i movimenti di resistenza civile iniziano a mobilitarsi. Come osserva Sharp, le élite di potere cercano abitualmente di indebolire i movimenti rompendo "la disciplina non violenta dei resistenti" e provocando la violenza del movimento attraverso una combinazione di "repressione severa" e impiegando "spie e agenti provocatori" per giustificare una repressione più intensa e per danneggiare il movimento agli occhi del pubblico. Questo ha in realtà un senso che viene definito “strategico” dall’autore, quando si comprende l'impatto negativo dell'attività violenta sull’intera manifestazione.
4. La violenza è una scelta, non una risposta obbligata
La modalità di repressione dei movimenti civili attraverso la violenza è una pratica di cui gli stessi attivisti o chi partecipa alle manifestazioni hanno preso piena coscienza ormai.
Per provare a capire il grado che le azioni violente calcolate hanno ormai raggiunto, il quotidiano francese indipendente Mediapart ha pubblicato di recente un’inchiesta che mette in evidenza proprio il ruolo sabotatore delle forze di polizia. Un ruolo che ha poco a che vedere con la volontà di rendere sicure le manifestazioni, di protezione e di gestione dell’ordine pubblico e che soprattutto, supera di molto il confine tra “garanzia di sicurezza” e “limitazione delle libertà di movimento e manifestazione”. Il primo e unico risultato che esse ottengono è la dispersione dei manifestanti, lo sfaldamento delle manifestazioni dovuto al pericoloso panico generale e, soprattutto, sempre più manifestanti riportano gravi danni fisici. Soltanto nel 2019, 25 persone hanno perso l’uso della vista a causa del lancio di proiettili di gomma, durante le manifestazioni dei Gilets jaunes e un’inchiesta della testata francese Street Press, ha rivelato che respirare il gas lacrimogeno durante le manifestazioni potrebbe avere delle gravi conseguenze sulla salute riproduttiva delle donne.
Per provare a ridurre l’uso della violenza della polizia durante le manifestazioni, già nel 2010 e fino al 2013, la polizia svedese capofila del progetto GODIAC (Good practice for dialogue and communication as strategic principles for policing political manifestations in Europe), che coinvolse 20 organizzazioni partner in 11 Paese europei e venne finanziato dalla CEPOL, agenzia europea di formazione delle autorità che contrastano la violenza, nello specifico i corpi di polizia.
Lo scopo del progetto, che evidenziava come, già nel 2010, fosse necessario un nuovo approccio dei corpi di polizia alla gestione delle manifestazioni, era proprio quello di condivisione ed elaborazione di nuove pratiche di intervento.
Il sito della CEPOL riporta come al termine del progetto, i Paesi che hanno aderito hanno potuto condividere report e studi di ricerca che sono stati poi utilizzati dalle varie polizie nazionali per programmare dei corsi di formazione e consapevolezza per i propri agenti. Peccato che, come spesso accade, chi più avrebbe bisogno, non ha la volontà: la Francia in questo caso, non ha partecipato ai lavori del progetto europeo GODIAC.
Una delle motivazioni è forse che, nel corso degli anni e in modo progressivo a partire dal 2015, la formazione degli agenti non è mai stata al centro delle agende di politica interna del governo Hollande prima e del governo Macron poi, che hanno aumentato conseguentemente invece, le limitazioni alla libertà di manifestazione e aumentato al tempo stesso i mezzi di repressione delle manifestazioni a disposizione delle forze di polizia. Più mezzi e meno formazione degli agenti, equivalgono a una maggiore violenza, quindi a manifestazioni che a mano a mano perdono di attrattività per chi intende manifestare e risultano dunque, meno efficaci.
Gli attacchi terroristici che, proprio dal 2015 hanno colpito la città, sono stati e continuano a essere il filo rosso e la più semplice giustificazione a questi inasprimenti di sicurezza.
Sul testo dell’ultima riforma di legge francese sulla sicurezza, dall’evocativo nome “Loi Sécurité Globale”, si legge: “Ogni attore dovrà avere un nuovo ruolo e trovare i suoi spazi, le sue specificità, per offrire ai francesi una sicurezza globale”.
Tra gli attori, i media e la stampa, sembrerebbero non dover avere più alcun ruolo all’interno delle manifestazioni, dal momento che la legge, in discussione questo mese in Senato, prevede all’art. 24, il divieto di filmare, o diffondere immagini che riportino il viso di un agente di polizia o di qualsiasi altra cosa utile alla sua identificazione.
Anche la stampa ha un ruolo importante nelle manifestazioni. La ripresa di una macchina che brucia, o di più feriti gravi è immediata ed evocativa, fa audience, ma al tempo stesso obbliga il prefetto che la vede ad agire con una forza repressiva molto più forte. Viene a crearsi così un cerchio di scelte e responsabilità reciproche in cui, le uniche che sembrano venire meno sono poi le più importanti: il dialogo e l’ascolto dei manifestanti.
La violenza è l’espressione più evidente della debolezza di un governo: “il vero potere unisce una comunità, mentre la violenza la distrugge. La violenza può sconfiggere il potere nel breve periodo, ma non può mai creare potere legittimo”, scrive Hannah Arendt nel suo “Sulla Violenza”.
(scarica l'analisi in pdf)
Note
[1] Steve Chase, “Facing the Problem of Agent Provocateurs”, working drafts, International Center on Nonviolent Conflict, settembre 2010.
Bibliografia
S. Chase, “Facing the Problem of Agent Provocateurs”, working drafts, International Center on Nonviolent Conflict, settembre 2010.
E. Chenoweth e K. Schock, “Do contemporaneous armed challenges affect the outcomes of mass nonviolent campaigns?, in Mobilization: An International Quarterly, vol. 2, n. 4, 2015, pp. 427-451.
A. Daillère, “Un autre maintien de l’ordre est possible”, in Humains, Acat France.
Intervista a Fabien Jobard, “Penser la police. Politiques du désordre”, 27 novembre 2020
Ministère de l'Intérieur, “Schema national du Maintien de l’ordre”, settembre 2020
Maintien de l’ordre: des méthodes différents en Europe”, La Depeche, 16 gennaio 2020
“Maintien de l’ordre: France vs Europe”, video-documentario di Brut.Original, 2 dicembre 2020.






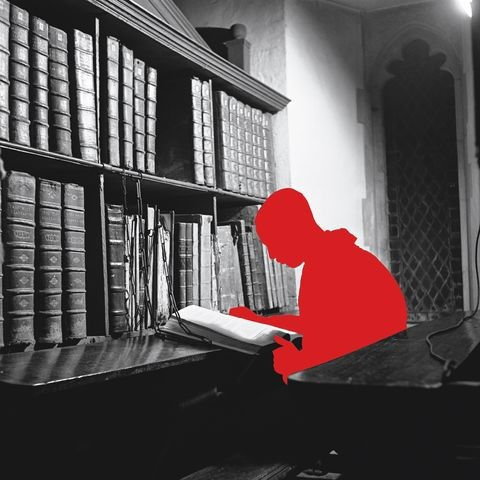


Commenti